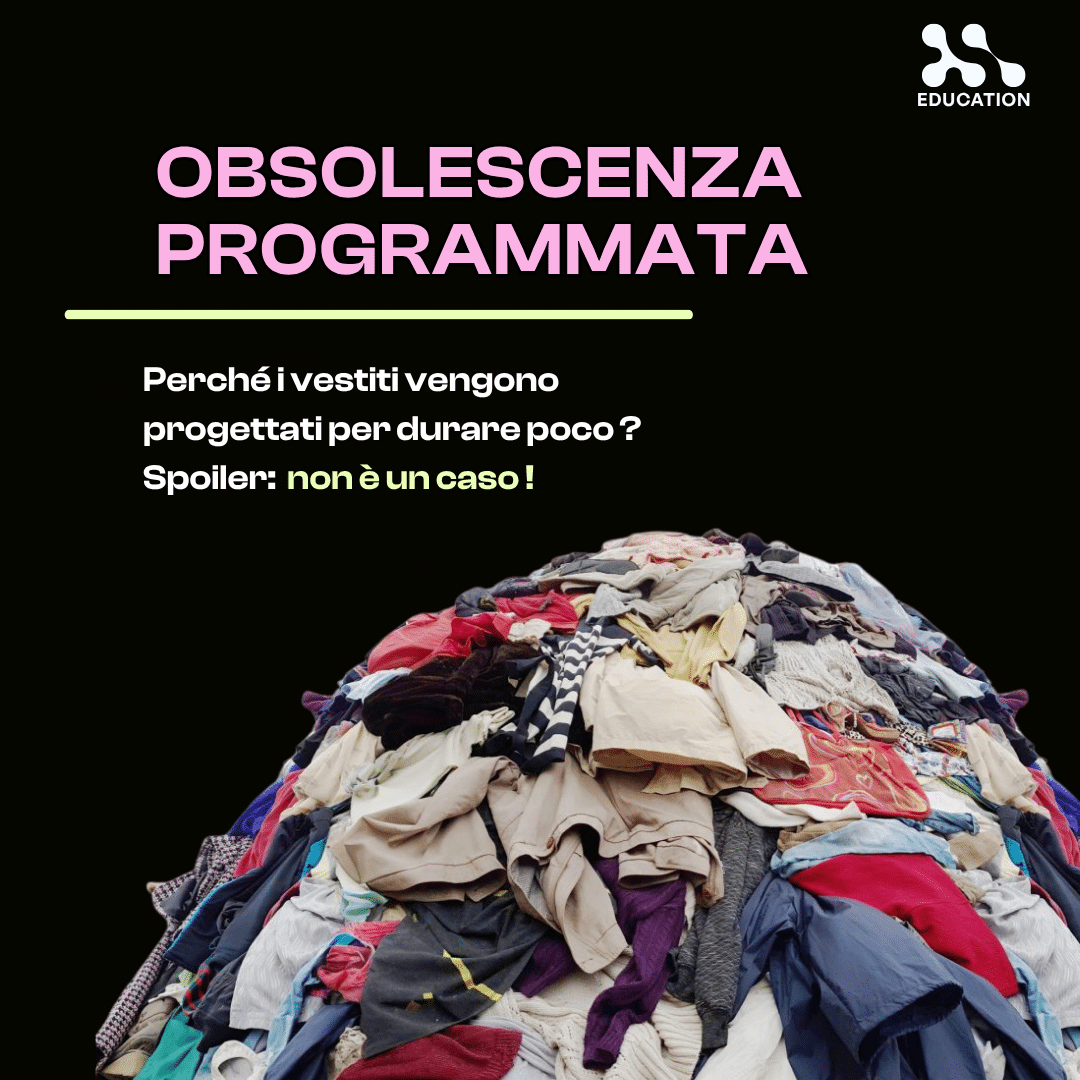L’obsolescenza programmata nella moda: storia, effetti e alternative sostenibili
L’obsolescenza programmata è una strategia adottata dalle aziende per indurre i consumatori a sostituire i propri prodotti più frequentemente di quanto sia realmente necessario. La moda è stato uno dei primi settori ad adottare questo modello, grazie alla creazione delle stagioni e alla produzione di indumenti di qualità inferiore, destinati a durare poco. Questo fenomeno, apparentemente legato al costume e allo stile, ha in realtà radici storiche profonde e conseguenze rilevanti sul piano sociale, economico e ambientale.
Origini storiche
Il concetto di obsolescenza programmata nella moda può essere fatto risalire al XVII secolo, durante il regno di Luigi XIV in Francia. Il sovrano, insieme al ministro delle finanze Jean-Baptiste Colbert, introdusse la stagionalità come strumento per stimolare l’economia. Alla corte di Versailles si impose l’idea che i vestiti dovessero essere rinnovati annualmente: nacquero così le stagioni autunno-inverno e primavera-estate, che rendevano rapidamente obsoleti i capi precedenti e incentivavano nuovi acquisti.
Questa logica venne poi ripresa e amplificata nei secoli successivi. Già nell’Ottocento, con la nascita della haute couture a Parigi, l’idea di moda come cambiamento rapido e continuo si consolidò. Con l’avvento della produzione industriale e dei grandi magazzini, tra fine Ottocento e inizio Novecento, la sostituzione dei capi divenne accessibile a una fascia di popolazione sempre più ampia, aprendo la strada al consumismo moderno.
Obsolescenza percepita e consumismo
Oggi, l’obsolescenza nella moda si manifesta soprattutto come obsolescenza percepita: i capi non diventano inutilizzabili, ma sono percepiti come “vecchi” o “fuori moda”. Il fenomeno è alimentato da strategie di marketing aggressive, da influencer e celebrità che dettano stili passeggeri e, soprattutto, dal ritmo frenetico delle collezioni.
Dai due cicli stagionali introdotti nel Seicento, siamo passati ai quattro stagionali delle maison del Novecento e, infine, all’accelerazione estrema del fast fashion: brand come Zara e H&M hanno introdotto collezioni settimanali, arrivando a produrre fino a 52 micro-collezioni l’anno. L’ultra fast fashion, rappresentato da Shein, ha ulteriormente esasperato questo modello, con migliaia di nuovi capi caricati online ogni giorno.
Impatti ambientali
Gli effetti di questo modello sono devastanti. Ogni anno vengono prodotti oltre 100 miliardi di capi di abbigliamento, molti dei quali indossati pochissime volte prima di essere scartati. Secondo l’ONU, il settore moda è responsabile di circa il 10% delle emissioni globali di CO₂ e del 20% dell’inquinamento idrico mondiale.
La produzione intensiva comporta:
uso massiccio di acqua (fino a 10.000 litri per produrre un paio di jeans),
inquinamento da sostanze chimiche usate nelle tinture,
enorme quantità di microplastiche disperse dai tessuti sintetici,
rifiuti tessili difficili da smaltire, spesso esportati nei Paesi del Sud del mondo, dove creano discariche a cielo aperto.
Conseguenze sociali ed economiche
Oltre all’ambiente, l’obsolescenza programmata nella moda ha forti ripercussioni sociali. La pressione per produrre a costi sempre più bassi alimenta lo sfruttamento della manodopera, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, dove i lavoratori tessili percepiscono salari minimi e operano in condizioni precarie.
A livello economico, l’obsolescenza programmata ha ridotto drasticamente il valore della riparazione e della sartoria. Mestieri come il rammendo, la modifica o il riuso dei tessuti sono stati progressivamente marginalizzati a favore dell’acquisto compulsivo di nuovi capi a basso costo.
Verso un’economia circolare
Di fronte a questi impatti, si fa sempre più urgente il passaggio verso un modello di economia circolare. Ciò significa prolungare la vita dei capi attraverso riparazione, riuso, upcycling e riciclo dei materiali. Alcuni Paesi stanno già sperimentando politiche innovative: in Francia è stato introdotto il cosiddetto “bonus rammendo”, che prevede incentivi economici per riparare vestiti e scarpe invece di sostituirli.
Anche le nuove generazioni stanno riportando in auge pratiche come il thrifting (acquisto di abiti di seconda mano), lo swap (scambio di vestiti) e il noleggio di capi per occasioni speciali. Parallelamente, nascono marchi indipendenti che puntano su materiali rigenerati e produzioni lente e trasparenti.
Conclusione
L’obsolescenza programmata nella moda non è soltanto un fenomeno economico: è una strategia che ha plasmato i nostri comportamenti e il nostro rapporto con i beni materiali. Radicata storicamente, è oggi una delle principali cause dell’insostenibilità del settore tessile.
La transizione verso modelli di consumo più lenti, consapevoli e circolari rappresenta non solo una necessità ambientale, ma anche un’opportunità culturale: riscoprire il valore dei nostri abiti, considerarli beni da curare e tramandare, invece che oggetti usa e getta.
A cura di Cosimo Martucci